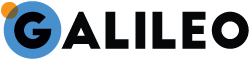Con l’intensificarsi dell’attività sismica nella zona dei Campi Flegrei (la scossa di magnitudo 4.4 della notte tra il 20 e il 21 maggio è stata la più forte degli ultimi 40 anni) la preoccupazione sale. Ma cosa prevede il piano di evacuazione della zona e quali sono i possibili scenari?
Un piano a zone
L’attuale piano di evacuazione definito dalla Protezione Civile divide l’area dei Campi Flegrei in due zone a rischio. La zona rossa è quella più a rischio di essere interessata dalle colate piroclastiche, ossia flussi di materiale magmatico e gas ad altissime temperature. Ci abitano oggi circa 500mila persone e comprende le località di Giuliano, Quarto, Marano (in parte), Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e le aree di Napoli Pianura, Bagnoli, Posillipo, Fuorigrotta, Chiaia, Soccavo, e in parte Vomero, Arenella, Chiaiano.
La zona gialla, invece, è la casa di circa 800mila persone distribuite in 24 quartieri di Napoli e in comuni limitrofi come Villaricca, Marano di Napoli, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Casavatore. Qui il pericolo è costituito dalla caduta di ceneri vulcaniche.
Dai Campi Flegrei un modello per prevedere le eruzioni dei vulcani
Quando bisogna evacuare
Il sistema di allerta definito dal Dipartimento della Protezione Civile prevede quattro livelli: verde, giallo (“attenzione”), arancione (“pre-allarme”), rosso (“allarme”). Il livello di allerta può cambiare in base ai dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in particolare dell’Osservatorio vesuviano, che monitorano il supervulcano flegreo in tempo reale. Ogni mese – si legge sul sito del Dipartimento della Protezione Civile – “si tiene una videoconferenza con i Centri di Competenza preposti all’attività di monitoraggio e la Regione Campania per analizzare le fenomenologie in atto e valutare la pericolosità vulcanica. Agli esiti delle videoconferenze vengono dichiarati i livelli di allerta”. Ogni sei mesi, poi, “il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il parere della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico, decide se confermare i livelli di allerta e le fasi operative (attenzione, preallarme e allarme) in stretto raccordo con la struttura di protezione civile della Regione Campania”.
Dal 2015 il livello di allerta della protezione civile è passato da verde a giallo. L’allontanamento della popolazione, a iniziare dalla zona rossa, è previsto all’innalzamento del sistema di allerta al livello rosso, cioè “allarme”. I cittadini che scelgono di allontanarsi con il trasporto assistito organizzato dalla Protezione civile devono recarsi nelle aree di attesa definite nei piani di protezione civile comunali, da cui verranno trasferiti nelle aree di incontro previste dalla pianificazione nazionale di protezione civile. Da qui è previsto il trasporto via nave, treno, pullman in Regioni e Province Autonome gemellate. La mappa dettagliata è disponibile sul sito della Protezione Civile.
I cittadini che, invece, scelgono di spostarsi con mezzi propri devono seguire i percorsi e l’apposita segnaletica stabiliti dal piano di allontanamento. Il flusso del traffico sarà gestito attraverso l’attivazione di cancelli, al fine di evitare ingorghi e incidenti.
Alla dichiarazione dello stato di allarme, le stime della Protezione Civile indicano un periodo di 72 ore per completare l’operazione di evacuazione. Le prime 12 ore consentono alle persone di prepararsi a lasciare l’area e alle autorità di predisporre le misure di regolazione del traffico. Le successive 48 ore sono dedicate alla “partenza contemporanea ma cadenzata della popolazione da tutti i Comuni della zona rossa, secondo un cronoprogramma definito nei piani comunali”. Le ultime 12 ore sono riservate come “margine di sicurezza per la gestione di eventuali criticità e per consentire l’allontanamento anche degli operatori del sistema di protezione civile”.
Uno scenario possibile
Non è possibile prevedere in modo esatto in quale momento il supervulcano dei Campi Flegrei erutterà, né quanti crateri si apriranno eventualmente e dove, o quanto durerà il suo risveglio. Il piano di evacuazione della Protezione Civile è disegnato sullo scenario ritenuto più probabile sulla base di uno studio che ha preso in esame gli ultimi 5mila anni di attività dell’area.
“In caso di riattivazione del vulcano, si avrebbe circa il 95% di probabilità che si verifichi un’eruzione minore o uguale a quella di taglia media”, che prevede la formazione di una colonna eruttiva alta fino a decine di chilometri, composta da gas e brandelli di lava incandescenti; la caduta di materiale vulcanico, sia di grosse dimensioni nell’area più vicina alla bocca eruttiva sia di ceneri e lapilli anche a diverse decine di chilometri di distanza, lungo la direzione del vento; lo scorrimento di flussi piroclastici (valanghe di gas, cenere e frammenti vulcanici, a velocità e temperature elevate) anche per alcuni chilometri. A questi fenomeni è possibile che si aggiungano esplosioni freatiche, cioè provocate dall’ebollizione e evaporazione di acqua superficiale a causa delle elevatissime temperature del magma.
Un piano da aggiornare?
L’intensificarsi delle scosse sta riportando l’attenzione su alcune criticità che potrebbero compromettere il buon esito del piano di evacuazione, per esempio la presenza di cantieri o addirittura chiusura delle strade indicate come vie di fuga. Le richieste vertono sull’aggiornamento delle vie di fuga, il controllo dello stato e della manutenzione delle infrastrutture e degli edifici, nonché l’integrazione di quanto emerso dallo studio dei flussi di persone e auto commissionato dalla Regione Campania.
Lo scorso 22 aprile è stata fatta una prova di evacuazione per gli scenari 1 (Danneggiamento limitato degli edifici localizzati in piccole porzioni di territorio) e 2 (Danneggiamenti più severi in porzioni più ampie di territorio e ad un numero significativo di edifici e infrastrutture). Il 30 e 31 maggio 2024 è prevista una prova di evacuazione per testare lo scenario 3, ovvero quello in cui le deformazioni del suolo subiscono un aumento importante in accelerazione e la sismicità aumenta in frequenza ed energia, provocando danni strutturali al sistema edilizio e infrastrutturale e criticità tali da non poter più garantire i servizi di base per i cittadini o comunque la convivenza con i fenomeni in atto.
via Wired.it